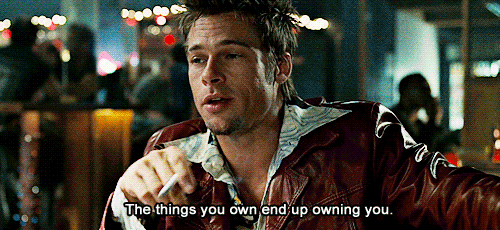In principio c’era il meme: New Martina e la ritualità della viralità
Qualche giorno fa, New Martina ha inaugurato il suo nuovo store.
File di adolescenti, cartelli colorati, cover per smartphone e una community pronta a dichiararsi “martinizzata”: non stiamo parlando di un concerto pop o di un lancio tecnologico, ma di una ragazza che ha trasformato il gesto apparentemente banale di applicare pellicole e cover in un impero mediatico.
La domanda, però, resta: perché ci appassiona così tanto la ripetizione di un gesto banale?
Dal panino alla pellicola: la forza della reiterazione
Il fenomeno rappresentato da Martina Fiorito non è isolato. Solo poco tempo fa, un altro creator diventava virale chiedendo sempre la stessa cosa: “Con mollica o senza?”.
Donato De Caprio, meglio noto come “Con Mollica o Senza”, ha costruito la sua notorietà - e anche lui, il suo locale - ripetendo un tormentone e trasformando il panino in un rituale digitale.
Cos’hanno in comune questi due casi?
Un gesto o una frase riconoscibile
La ripetizione continua, fino a diventare tormentone
La capacità di generare appartenenza: chi conosce il format “fa parte del gruppo”, chi non lo conosce resta escluso
Con mollica o senza?
In principio c’era il meme
La dinamica è la stessa che governa la cultura dei meme: un’unità culturale semplice, riconoscibile, replicabile. Il meme è forte perché è:
ripetibile
variante (ognuno ci mette un twist personale)
condivisibile
identitario (chi lo capisce è dentro, chi non lo capisce è fuori)
Nasce il format – un gesto/frase semplice
Ripetizione – si fissa nella memoria collettiva
Variazione – parodie, remix, versioni personali
Diffusione – l’algoritmo e la community lo spingono
Appartenenza – diventa linguaggio identitario
Saturazione o mutazione – o si esaurisce, o evolve in altro meme
Prima ancora di TikTok, prima degli influencer, c’era la dinamica culturale della ripetizione, della variazione e della diffusione virale.
Se ci pensiamo, le barzellette che giravano a voce negli anni ’80-’90 erano già meme, i tormentoni televisivi (“A me mi piace!”, “È la Juve!”) erano meme prima che li chiamassimo così, persino le filastrocche popolari o i proverbi funzionano come meme: unità semplici, ripetibili, condivisibili.
TikTok e i social non hanno inventato la logica, l’hanno solo accelerata, codificata e monetizzata. Diventare virali farcendo un panino o cambiando la pellicola a uno smartphone è il frutto di una stessa dinamica antichissima: il piacere collettivo di riconoscere e ripetere.
La radice antica della ripetizione
Quella fascinazione che proviamo oggi davanti a un trend virale non nasce certo con i social, infatti. È qualcosa di molto più antico, che appartiene alla storia dell’umanità.
Da sempre le comunità umane si stringono attorno alla ripetizione. Nei riti religiosi e sociali tornano gli stessi canti, le stesse preghiere, le stesse processioni. Ripetere serve a dare ordine e prevedibilità in un mondo che altrimenti sembra caotico: rassicura, dà sicurezza, fa sentire parte di un gruppo.
Freud parlava di “coazione a ripetere”: quella spinta quasi naturale che ci porta a rifare gesti ed esperienze come se così potessimo dominarle o elaborarle meglio. E non è solo questione di inconscio: impariamo ripetendo. L’imitazione e la reiterazione sono alla base di qualsiasi apprendimento.
La ripetizione, poi, non è solo necessità: è anche estetica, è piacere. Basta pensare al ritmo delle percussioni nei canti tradizionali o al ritornello di un brano pop che non riusciamo a toglierci dalla testa. Nell’arte visiva, i mosaici, i mandala, le decorazioni fatte di motivi che tornano e ritornano hanno da sempre una funzione meditativa, quasi ipnotica.
E ancora: i grandi miti e le epopee antiche, da Omero al Mahabharata, sopravvivevano grazie a formule fisse e strutture ripetitive, che rendevano possibile la trasmissione orale. La ripetizione non era un difetto, ma uno strumento: serviva a ricordare, a tramandare, a non perdere la memoria collettiva.
In fondo, potremmo dire che ripetere è il modo più umano che abbiamo trovato per rendere il mondo comprensibile. È ritualità, conforto, comunità.
Se guardiamo ai trend di TikTok o di Instagram da questa prospettiva, non sembrano altro che la versione secolarizzata dei riti di un tempo. Si ripete un gesto o una frase, lo si condivide, ci si riconosce dentro una comunità. In altre parole, i meme e i format virali sostituiscono oggi i rituali collettivi tradizionali, offrendo appartenenza e rassicurazione attraverso il digitale.
Si ripete un gesto o una frase, lo si condivide, ci si riconosce in una comunità.
E questa sensazione di appartenenza culmina con l’illusione finale: se compri, appartieni di più.
Fight Club, 1999
Dal rito al trend
Quello che ieri era messa, processione o barzelletta, oggi prende la forma di un trend virale. Il gesto di Martina diventa una sorta di preghiera digitale: migliaia di ragazzi che guardano, imitano, seguono. Il tormentone di Donato diventa linguaggio comune: un codice che circola dentro e fuori la rete.
In entrambi i casi, la forza non è tanto nel contenuto (una cover applicata o un panino farcito), quanto nel rituale condiviso. E in quanto efficace sia questo rituale nel condurci verso un acquisto che si trasforma in un manifesto d’appartenenza sociale.
Marketing e antropologia della viralità
Per chi studia comunicazione e marketing, questi fenomeni ci insegnano tre cose fondamentali.
Il potere della semplicità: un gesto banale, se ritualizzato, diventa marchio
La ripetizione come branding: non serve un logo, basta un tormentone riconoscibile
Il bisogno di appartenenza: i trend virali non sono solo intrattenimento, ma strumenti di identità sociale
L’apertura dello store di New Martina non è solo l’espansione commerciale di una creator, ma un segnale culturale: la ritualità della ripetizione si è spostata nei social e continua a governare la nostra attenzione ma anche le nostre abitudini d’acquisto.
In questo senso, il rito digitale non si limita a produrre intrattenimento: diventa motore di consumo. Acquistare una cover di New Martina o andare a mangiare un panino “con mollica o senza” non significa soltanto comprare un oggetto o un pasto. Significa partecipare al rito, dichiarare pubblicamente la propria appartenenza a una comunità.
Il gesto di acquisto viene così caricato di un valore simbolico: non è più solo transazione economica, ma manifesto identitario. Ogni prodotto diventa un segno, un lasciapassare che ci dice “io ci sono, faccio parte del gruppo”.
Eppure, al fondo, resta consumo. Un consumo che si traveste da esperienza condivisa, che prende in prestito le dinamiche della ritualità per moltiplicarne la forza. In altre parole: il rito ci rassicura, ci unisce, ci diverte — e intanto ci accompagna con leggerezza verso la cassa.
Homo consumens
Cambiano i linguaggi, cambiano i media, ma resta lo stesso bisogno antico, profondamente umano: ripetere insieme per sentirsi parte di qualcosa.
Oggi, però, questa energia arcaica si intreccia con le logiche del mercato. Il rito non vive più solo nella sfera del sacro, ma diventa carburante del consumo. In fondo, potremmo chiamarci non più homo sapiens, ma Homo consumens: creature che trovano identità e appartenenza non solo nei gesti che ripetono, ma negli oggetti che acquistano per dimostrarlo.